La libertà di pensare e il diritto alla mente inviolabile
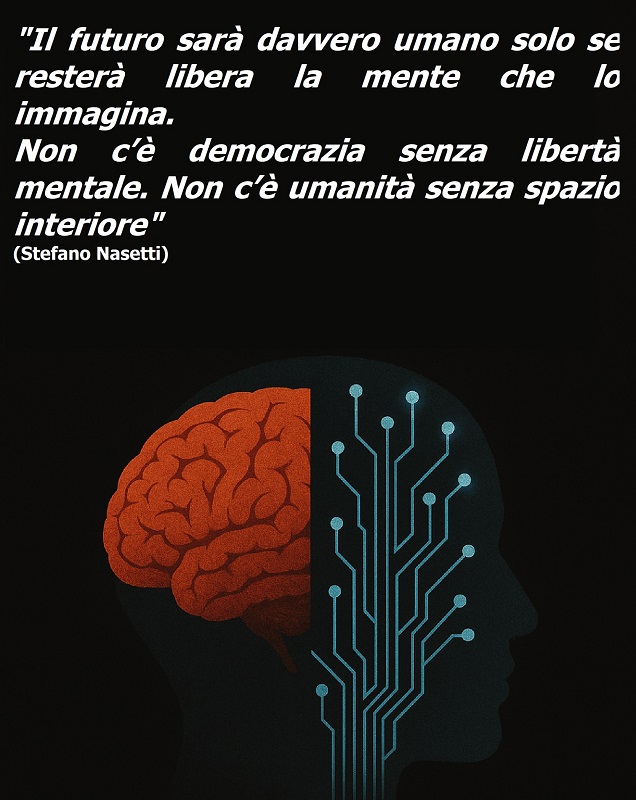
Il mondo sta evolvendo rapidamente. L'opinione pubblica viene messa al corrente delle evoluzione tecnologiche solo quando chi le ha sviluppato e ne detiene il controllo, decide di farlo sapere. Spesso ciò avviene quando la conoscenza dell'esistenza di tali tecnologie è conveniente, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello del controllo sociale, per chi le governa.
Va da se che fino all'ultimo istante, tecnologie innovative e sempre più pervasive della società e della natura umana stessa, vengano considerate, nella mente dell'opinione pubblica, solo delle distopiche fantasie da serie TV o, in un epoca in cui etichettare chi la pensa diversamente (o meglio, chi semplicemente pensa con la propria testa) e si interessa di argomenti non mainstream, delle fantasie da "complottisti".
Nel frattempo, mentre tutti dibattono sui temi che il mainstream propone di giorno in giorno o di periodo in periodo, spesso utilizzati per distrarre l'opinione pubblica dalle cose realmente importanti, queste tecnologie fanno il loro silenzioso ingresso nella società, trovando man mano sempre più diffusione, accompagnate solo dall'opinione degli "esperti" che ne decantano le lodi e ne silenziano i pericoli e i difetti. Lo abbiamo visto continuamente nel corso di questi ultimi anni ed esempio sono facili da trovare. Si va dalla diffusione di internet, a quella degli smartphone, dall'utilizzo superficiale dei social a quello di tutte le cosiddette tecnologie "smart" (ciò "intelligenti") che intelligenti non sono, fino proprio alla diffusione dei sistemi algoritmici oggi chiamati impropriamente "Intelligenze Artificiali" (al più definibili come "IA deboli"). E se, come detto nell'articolo precedente e nel mio ultimo lavoro editoriale, il dibattito su queste tecnologie avviene solo in merito a come e dove applicarle e mai sul se o non applicarle, la discussione finisce spesso per essere sterile, poiché interviene a cose ormai già fatte: le eventuali modifiche legislative originate dal dibattito pubblico, potranno essere al massimo solo correttive e, per lo più solo limitatamente.
È quindi importante che dibattiti su tecnologie altamente impattanti sull'organizzazione sociale o, addirittura, sui diritti umani e sulla natura dell'umanità stessa, intervengano a stimolare il processo legislativo che dovrebbe regolare l'applicabilità, prima che queste tecnologie comincino ad essere utilizzate, a diffondersi e a cambiare il mondo. Se è normale che con il tempo il mondo cambi, il cambiamento non va sempre considerato positivo. La storia è lì a testimoniarlo.
Le interfacce cervello-computer (BCI - Brain-Computer Interface) stanno rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Questi sistemi avanzati sono progettati per raccogliere segnali cerebrali, interpretarli e utilizzarli per controllare dispositivi esterni, come computer, protesi robotiche, o persino droni. Grazie a queste tecnologie, è oggi possibile tradurre i pensieri in parole, immagini, o azioni fisiche. Sebbene lo sviluppo di queste tecnologie finalizzate al controllo mentale risalga addirittura agli anni '50 del secolo scorso, con il famoso progetto della CIA (sempre etichettato come fantasia complottista e oggi invece non più negabile a seguito della diffusione pubblica dei documenti ufficiali da parte dell'agenzia statunitense) MKUltra, è con l'avvento dei sistemi algoritmici e dei supercomputer (e a breve anche con i computer quantistici) che c'è stata un'accelerazione nel loro sviluppo e un ampliamento nei possibili campi di applicazione. Ecco una breve sintesi di come funzionano e cosa sono in grado di fare già oggi, prima di capire il perché è importante cominciare a parlarne.
Le interfacce cervello-computer (BCI), come detto, sono dispositivi che permettono una comunicazione diretta tra il cervello umano e un computer. Utilizzano tecnologie come l'elettroencefalogramma (EEG) per misurare l'attività elettrica del cervello, e successivamente interpretano i segnali in modo da tradurli in comandi per un dispositivo esterno. Un esempio è quello relativo a persone con disabilità motorie gravi, come la paralisi, possono utilizzare questo tipo di interfacce cervello-computer per controllare un computer o una sedia a rotelle con i pensieri, senza necessità di movimenti fisici. Sistemi come BrainGate utilizzano elettrodi impiantati nel cervello per decodificare le intenzioni di movimento e attivare una protesi robotica, consentendo a chi ha perso l'uso di un arto di eseguire movimenti complessi.
C'è poi il neurofeedback, una tecnica che consente alle persone di monitorare e regolare la propria attività cerebrale in tempo reale. Utilizzando sensori EEG, il neurofeedback permette agli individui di "allenarsi" a migliorare funzioni cerebrali specifiche, come la concentrazione o la gestione dello stress. Ad esempio, in alcuni studi, il neurofeedback è stato utilizzato per permettere agli utenti di controllare dispositivi esterni, come videogiochi o droni, semplicemente cambiando lo stato mentale, come focalizzarsi su un obiettivo o rilassarsi. Questi sistemi offrono anche applicazioni terapeutiche, come il trattamento della sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) o dei disturbi d'ansia, migliorando la regolazione delle onde cerebrali. Sono già utilizzati da alcuni anni nel controllo di alcuni sistemi di arma nei droni e nei caccia militari statunitensi.
La decodifica delle onde cerebrali invece, è una tecnologia emergente che cerca di interpretare i pensieri o le immagini mentali delle persone attraverso segnali cerebrali. Tecniche avanzate come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) o elettrodi impiantati vengono usati per monitorare l'attività cerebrale e "decodificare" contenuti come immagini mentali o intenzioni verbali. Un esempio a riguardo: in ricerche avanzate, gli scienziati sono riusciti a "leggere" le immagini mentali di una persona osservando l'attività cerebrale. Utilizzando fMRI, è stato possibile ricostruire immagini visive simili a quelle che il soggetto stava visualizzando. Un altro esempio è l'interpretazione dei segnali cerebrali per tradurre pensieri verbali in parole scritte o parlate, aprendo la strada alla comunicazione per persone con gravi disabilità.
Le tecnologie di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) stanno integrando sempre più i segnali cerebrali per creare esperienze interattive e immersive che si adattano ai pensieri dell'utente. Combinando le interfacce cervello-computer e ambienti virtuali, queste tecnologie non solo permettono interazioni più naturali, ma anche il miglioramento delle capacità cognitive. Nel settore della riabilitazione, ad esmepio, alcuni studi usano AR e VR per aiutare i pazienti a recuperare funzionalità motorie. L'attività cerebrale viene monitorata in tempo reale per personalizzare il trattamento e ottimizzare la risposta fisiologica del paziente. Allo stesso modo, giochi e simulazioni di realtà virtuale possono essere controllati con il pensiero, creando un'esperienza più immersiva.
L'uso di sistemi d algoritmici di intelligenza artificiale debole (IA) e machine learning ha migliorato significativamente la capacità delle interfacce cervello-computer di decodificare i segnali cerebrali. Gli algoritmi di IA sono in grado di riconoscere modelli complessi nei segnali cerebrali, migliorando la precisione delle interazioni cervello-computer e aumentando l'affidabilità e la velocità con cui vengono tradotti i segnali in azioni. Neuralink, la società di Elon Musk, sta lavorando (ed ha già sperimentato con successo) a impianti cerebrali che utilizzano l'IA per interpretare segnali cerebrali e collegarli a dispositivi esterni. Il progetto mira non solo a trattare malattie neurologiche come il Parkinson, ma anche a rendere possibile la comunicazione tra cervelli umani e dispositivi elettronici, potenzialmente creando una sorta di "telepatia digitale". Un ultimo esempio è di pochi giorni fa (Fonte Ansa) in cui questi sistemi sono stati in grado di leggere la mente attraverso una analisi delle espressioni facciali e dei micromovimenti del volto.
Se da un lato queste tecnologie offrono incredibili opportunità – dalla riabilitazione fisica alla comunicazione per chi è affetto da malattie debilitanti – dall'altro sollevano importanti questioni etiche e pratiche. La mente umana sta diventando la prossima frontiera della raccolta dati di massa e dalla profilazione individuale, con tutto ciò che questo comporta. La capacità di "leggere" o addirittura "scrivere" nei pensieri di una persona "vedere e immagini" che una persona pensa, potrebbe sollevare preoccupazioni sulla privacy, sul controllo mentale e sulla sicurezza dei dati cerebrali.
Le tecnologie che sfruttano i segnali cerebrali stanno trasformando il nostro rapporto con la tecnologia, creando nuove possibilità per la comunicazione, il trattamento delle malattie e l'interazione con il mondo digitale. Mentre la ricerca continua a fare passi avanti, queste innovazioni potrebbero un giorno rendere possibili comunicazioni "telepatiche" o esperienze virtuali controllate completamente dal pensiero. Tuttavia, l'equilibrio tra innovazione e considerazioni etiche rimarrà una questione cruciale nei prossimi anni.
Ed è questo il punto principale su cui, già oggi, si dovrebbe già concentrare il dibattito pubblico affinché l'utilizzo di queste tecnologie non diventi pericolo lesivo delle libertà e dei diritti umani.
[… Abbiamo attraversato un tempo di illusioni digitali. Abbiamo dato voce a macchine che non parlano, attribuito intenzioni a sistemi che non pensano, e iniziato a chiedere all'intelligenza artificiale di dirci chi siamo.
Ma ora qualcosa di più profondo sta accadendo.
Non è più solo questione di linguaggio. È la mente stessa che rischia di diventare trasparente, leggibile, decifrabile.
Per la prima volta nella storia, il pensiero umano non è più considerato inviolabile.
Con l'avvento di tecnologie in grado di leggere, interpretare e decodificare segnali neurali, la dimensione mentale dell'essere umano — storicamente considerata inviolabile — è diventata un potenziale oggetto di misurazione, sorveglianza e intervento.
In questo scenario, non possiamo più limitarci a regolare l'uso degli strumenti. Dobbiamo riaffermare chi siamo.
Dobbiamo riconoscere che la mente non è solo un organo biologico né una fonte di dati: è lo spazio originario della libertà umana.
Se l'attività cerebrale diventa codice, e la mente un'interfaccia con il mondo, allora è tempo di affermare un nuovo principio:
la libertà cognitiva è un diritto umano fondamentale.
Non possiamo più difendere solo la parola, il corpo o i dati. Dobbiamo ora difendere il pensiero stesso. Perché ogni coscienza è uno spazio sacro. E ogni mente, un universo inviolabile.
Questo "Manifesto Cognitivo" non è una provocazione ideologica. Non è un atto retorico, ma una necessità politica, etica e giuridica. Una proposta concreta: riconoscere il diritto al pensiero — e non solo alla sua espressione — come diritto umano fondamentale.
Un appello a tutelare la libertà cognitiva e sancire giuridicamente i diritti mentali, nell'epoca della simbiosi tra uomo e macchina.
Un tentativo di scrivere oggi, in tempo, ciò che rischiamo di rimpiangere domani: un principio di protezione della nostra coscienza, della nostra opacità, della nostra capacità di pensare senza essere letti.
Se nel Novecento abbiamo imparato a difendere il corpo, oggi dobbiamo imparare a difendere la mente.
Non c'è cittadinanza piena senza libertà mentale. Non c'è umanità senza uno spazio interiore che nessuno, neppure la macchina più evoluta, possa violare…]
[... una nuova stagione di consapevolezza, in cui il pensiero non sia solo oggetto di studio, ma soggetto di diritto.
Articoli del Manifesto Cognitivo
Art. 1 –Libertà Cognitiva
Ogni individuo ha il diritto alla libertà del pensiero e alla non intrusione cognitiva. Nessuna tecnologia, pubblica o privata, può accedere, monitorare, tracciare, decifrare, influenzare l'attività cerebrale umana senza consenso esplicito, consapevole e revocabile.
Art. 2 – Integrità Mentale e Segretezza interiore
L'attività cerebrale è parte integrante dell'identità personale. La mente non è un bene pubblico. Anche nella sua espressione digitale, l'interiorità deve restare libera dalla sorveglianza, dalla profilazione e dalla manipolazione.
Il diritto alla integrità mentale implica che nessun sistema algoritmico possa alterare intenzioni, emozioni o pensieri senza limiti giuridicamente stabiliti.
Art. 3 – Consenso cognitivo
Nessuna tecnologia può accedere, registrare o interpretare l'attività neurale di un individuo senza un consenso libero, specifico, informato e revocabile in ogni momento, secondo principi di bioetica applicati alle neuroscienze.
Art. 4 – Sovranità mentale: diritto alla segretezza del pensiero
Ogni essere umano è il solo proprietario dei propri pensieri. È garantito il diritto alla riservatezza mentale, ovvero il diritto a non essere letto, predetto o decodificato da alcun sistema, anche quando ciò sia tecnicamente possibile. Il pensiero non espresso non è un dato. Non è disponibile, né estraibile.
Nessun sistema, istituzione o azienda può rivendicarne il controllo, la proprietà o la previsione.
Art. 5 – Sovranità dei Dati Neurali
I segnali cerebrali e i contenuti mentali decodificati sono dati ultra-sensibili. Appartengono esclusivamente al soggetto che li genera e non possono essere ceduti, elaborati o condivisi senza garanzie equivalenti a quelle previste per i dati biometrici e sanitari.
Art. 6 Diritto all'Opacità Cognitiva
Ogni individuo ha il diritto a non essere trasparente: ambiguità, silenzi e stati mentali non comunicati costituiscono elementi legittimi dell'identità personale e non devono essere forzati alla decodifica.
La trasparenza mentale non può diventare obbligo.
Art. 7 – Equità cognitiva
L'accesso a tecnologie di interfaccia neurale deve essere equo, inclusivo e non discriminatorio. Deve garantire che nessuna disuguaglianza cognitiva o economica determini nuove forme di esclusione digitale.
Art. 8 – Limite all'ibridazione
Qualsiasi integrazione tra mente umana e sistema tecnologico deve rispettare il principio di proporzionalità e finalità etica. La simbiosi uomo-macchina non può ridurre l'essere umano a terminale operativo né svuotarne l'autonomia decisionale.
Ogni fusione tra cervello e IA deve essere orientata al benessere umano, non alla sua sostituzione.
Art. 9 – Clausola di Non Regressione
Nessun progresso tecnologico potrà mai giustificare la regressione dei diritti cognitivi già acquisiti. Le innovazioni devono sempre rafforzare e non indebolire la protezione della libertà mentale e della sovranità individuale.
Art. 10 – Interesse Commerciale e Brevetti
È vietato brevettare, commercializzare o vendere tecnologie invasive dell'interiorità mentale senza garanzie etiche, giuridiche e umane stringenti, volte a tutelare la dignità, la privacy e l'autonomia dell'individuo.
Art. 11 – Protezione Giuridica Globale
Si richiede l'introduzione, a livello internazionale, di una Carta dei Diritti Cognitivi che estenda le tutele previste dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani al dominio mentale, come già proposto da iniziative accademiche e scientifiche.
Art. 12 – Vigilanza Democratica
La governance delle neurotecnologie deve essere trasparente, pubblica e sottoposta a controllo democratico. Ogni uso militare, coercitivo o manipolativo di sistemi mentali artificiali deve essere vietato e considerato crimine contro l'umanità.
Conclusione
La mente è il fondamento dell'esperienza umana. In un'epoca in cui essa può essere letta, tradotta o persino modificata da macchine intelligenti, occorre istituire un nuovo patto etico e giuridico che riconosca la cognizione come bene inviolabile.
Non è la macchina che ci minaccia. È la nostra cedevolezza nel concederle ciò che abbiamo di più intimo: il pensiero.
Il futuro sarà davvero umano solo se resterà libera la mente che lo immagina.
Non c'è democrazia senza libertà mentale. Non c'è umanità senza spazio interiore…]
(brano tratto dal libro: "L'illusione dell'intelligenza artificiale" – Stefano Nasetti – ed.2025)
© Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche solo parziale dei contenuti di questo articolo, senza il consenso scritto dell'autore
